*Articolo tradotto dalla versione inglese
Ci sono album musicali che prendono spazio nella nostra vita perché legati ad un momento specifico o perché si adattano perfettamente ai nostri gusti di ballo o al nostro pensiero. Il nostro tempo, il nostro senso del tempo, è plasmato da incontri ed esperienze e, la musica spesso ne fa parte: grandi eventi (politici o sociali) e piccoli (cose che accadono nella quotidianità che cambiano inaspettatamente il nostro percorso) possono avere effetti anche drammatici (come in questa dura pandemia) ma ciò che rimane oltre il momento, oltre questi giorni, sono le cose che vengono a formarsi, inaspettatamente, la cornice dei nostri pensieri e il modo in cui percepiamo il mondo.
“Boxer” ha tutte queste qualità per me e ancor di più, è capace di plasmare il mio umore, di portarmi in un luogo che conosco, o conoscevo, ma che ogni volta è cambiato, cambiato perché non sono più la stessa, ma perché una volta lo ero. È come se avesse la forza di attraversare il tempo e le esperienze, tra la vita di un prima e la mia vita di oggi, in una sorta di slow motion, come in un film in cui la pellicola che scorre nella macchina da presa accelera ma, al contrario, sembra rallentare il tempo, un’elasticità che scopre un’altra logica all’interno delle esperienze.

Si tratta di un album che ha la capacità di chiarire le mie percezioni e le mie opinioni sul mondo e soprattutto, sulle relazioni sociali. Forse, per questo motivo, questo apparente mutamento percettivo, come avviene con l’immagine tremolante che si ha quando l’otturatore si apre e si chiude a velocità incostante, come quando lo sguardo è rapito da un dettaglio durante il passaggio veloce di un treno, una cosa diventa la conseguenza di un’altra, parte di un ricordo che, mi porta a pensare ad altre esperienze, così come i pensieri si susseguono mentre scrivo questo testo. In realtà, già il titolo, perché è legato alla musica, ha una forte risonanza nella mia memoria, quasi come un’ebbrezza: il pugile come paradigma di vita, di battaglia, di resistenza, di lotta fino all’ultimo round. Mi ricorda l’entusiasmo appassionato di mia madre per Muhammad Ali, sorprendente e toccante nell’Italia provinciale di una vita fa, così come mi ricorda l’amore romantico-complicato di Edith Piaf per Marcel Cerdan di cui una volta ho letto, oppure di Claude Cahun, la quale, esplorando e delineando la sua identità per sfuggire alla camicia di forza del conformismo che la soffocava, provava vestiti e personaggi (forse conoscete le foto, le sue “Training Series” di fine anni ’20) dove indossa una divisa da pugile, audace e provocante… mettendosi in gioco. (Ma merita uno dei miei prossimi post, merita di più).
In queste foto, indossa un costume da pugile ma, allo stesso tempo, un trucco molto femminile con una maglietta su cui ha disegnato i suoi capezzoli e la frase “Mi alleno, non baciarmi”, circondata da cuori. Infatti, la sua lotta, lungo tutta la sua vita per affermare la sua sessualità, trova nell’immagine del pugile il modo perfetto per esprimere la sua duplicità: da un lato una grande forza per affermare pienamente se stessa, ma anche, dall’altro, quell’atteggiamento malinconico di chi ha in fondo la certezza che il mondo intorno a lei non sarebbe mai potuto essere adatto alla sua sessualità fluida.
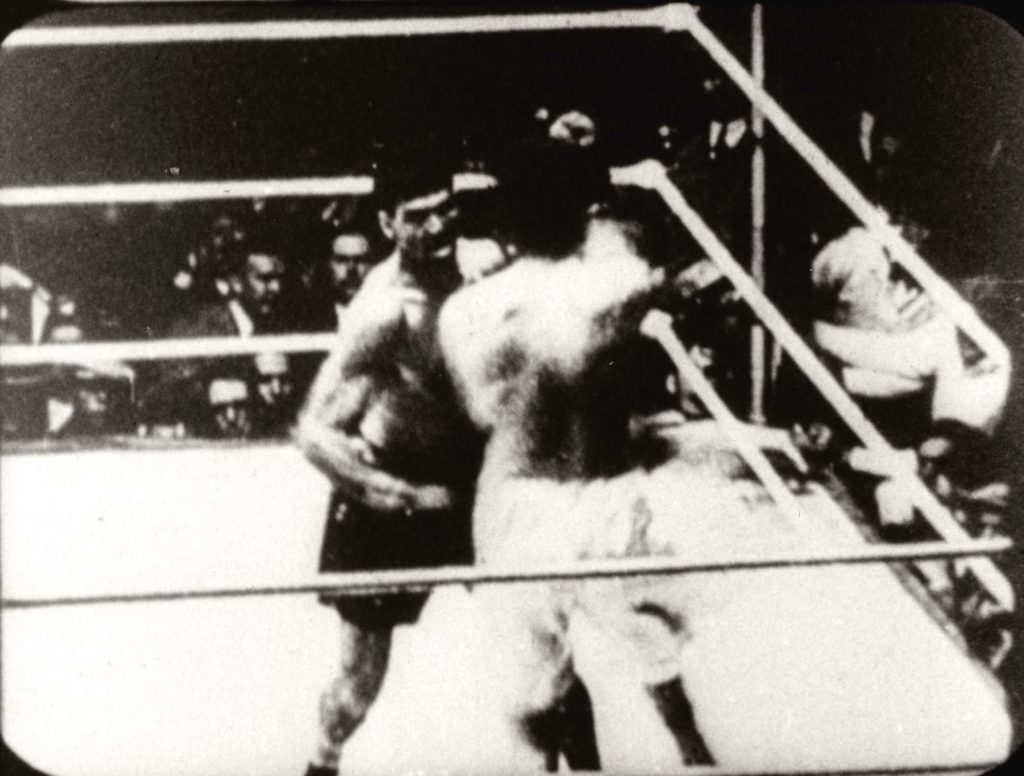
Da qui la memoria fa un salto ulteriore, uno spostamento di tempo e di luogo, verso il misterioso loop di “Box (ahhareturnabout)” di James Coleman del 1977, senza dubbio la sua opera più significativa, la sua unica grande opera. Un film di pochi minuti, un frammento di celluloide granulosa in bianco e nero dell’incontro Tunney contro Dempsey del 1927. I cinquant’anni che intercorrono tra la realizzazione del film e il suo recupero da parte di Coleman, sono di per sé un loop temporale ed inquietante. Coleman ha ricontestualizzato il materiale del film, senza farlo assimilare alla materia del presente, alla familiarità dell’oggi ed al processo di omogeneizzazione del passato, diventando materiale per la lettura contemporanea, spogliandolo del suo essere grezzo.
Fa qualcosa che l’arte come appropriazione non fa mai. Invece del feticismo dei significati del passato, che è l’unica traccia di una noiosa ripetizione di oggetti già assimilati, scoloriti di ogni vigore, il film, trattato e montato, rimane altro, estraneo, al di fuori sia del suo che, del nostro tempo. In una sorta di spazio tra memoria ed identificazione senza il processo di riconciliazione con un presente familiare o con la storia. Il montaggio del film converte in descrizione visiva il suono dei movimenti dei pugili e, i movimenti di quest’ultimi, con il fragore del pubblico. Enfatizzando ritmo e la ripetizione.
Ma ecco ciò che lo rende unico: anche se si guarda questo film senza sonoro, che è poi quello che lo caratterizza e lo rende arte, il film mantiene una sua aurea, distante e allucinatoria. L’opera di Coleman è un’opera di trasmissione. Le voci degli spettatori che, seguono il match, diventano parte della narrazione di ciò che stanno guardando: gli spettatori, noi, e i pugili si uniscono nella narrazione di un match. Le immagini tremolanti fluttuano nel tempo e nello spazio: in questo diventa chiaro il suo legame profondo con l’album dei The Nationals. Il senso dell’interrelazione ed il senso della narrazione collettiva.
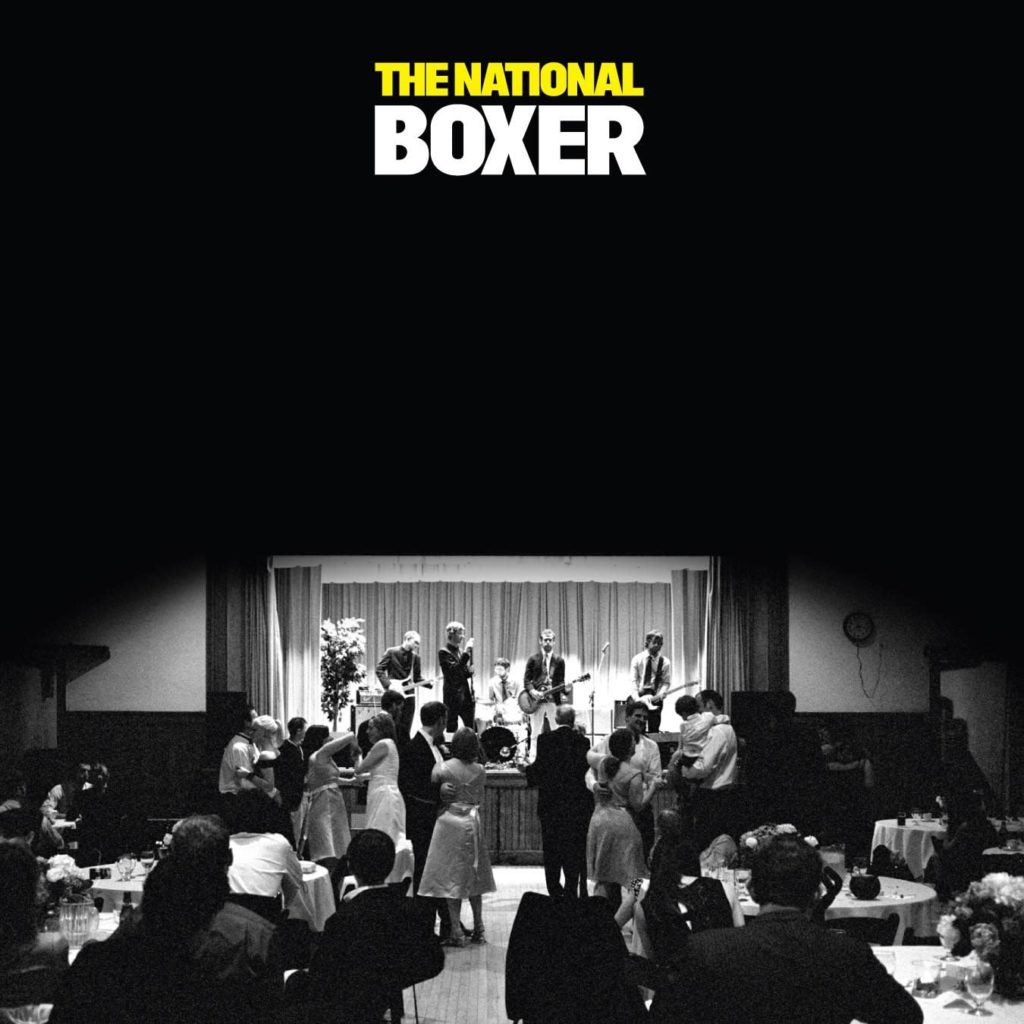
“Boxer” ha nella canzone “Slow Show” una delle chiavi di lettura , la metafora del pugno e, come nel film di Coleman, un senso di tempo instabile, di esperienza lenta, come la scena sulla copertina dell’album: una foto in bianco e nero del gruppo che suona alla festa di matrimonio del loro produttore, sembrando allo stesso tempo, una messa in scena o uno scatto d’altri tempi, un’immagine familiare e anche sconosciuta, apparentemente riconoscibile ma instabile. Una narrazione che viene sottolineata nella linea melodica, nell’arrangiamento e nei testi di tutto l’album. Nel disco, l’ intimità, le piccole scene di vita quotidiana, l’identificazione e la comunità, si collegano tra loro lungo una narrazione complessiva oscillante.
I membri del gruppo, pur essendo tutti di Cincinnati, hanno formato The National a New York tra il 1999 e il 2000, all’inizio del nuovo millennio, con il relativo carico di speranza per il futuro, ma anche, come tutti sappiamo, poco prima degli eventi dell’11 settembre, che hanno drammaticamente aperto una nuova era fatta di paure ed incertezze. Un tempo tragico in cui la paura ha cambiato il nostro modo di percepire l’altro, in cui ci è stato chiesto di essere cauti e attenti agli spazi affollati, un tempo in cui il nostro modo di viaggiare è cambiato definitivamente (ed è ancora così, e ancora oggi viviamo lo stesso tipo di auspicio, anche se l’oggi è costellato da un triste numero di morti maggiore e da un diverso senso di confusione).
Proprio nel periodo in cui si iniziava una fase di elaborazione di questi eventi drammatici, i The National pubblicano “Boxer”, il loro quarto album uscito nel 2007, con il quale passano a quella alchimia più strutturata tra testi e orchestrazione che li avrebbe resi famosi: infatti, ascoltare le canzoni, una dopo l’altra, trasporta l’ascoltatore nel loro doppio loop, tra speranze e malinconia, tra gli spazi urbano e quelli intimi, tra ciò che sarebbe stato possibile e ciò che invece è la vita nella società contemporanea.
È un viaggio unico, fatto attraverso un susseguirsi di scene, momenti e gesti, piccole polaroid della vita quotidiana, così vivide che, in ogni testo c’è uno spazio personale, collettivo/privato, di partecipazione.
Il beat insistente del batterista, insieme alla ripetizione calcolata della stessa frase più volte in uno stesso testo, danno un ritmo alla narrazione che appare molto vicina a quello del film di Coleman e contribuisce a creare quel senso di tempo prolungato, scandito lungo tutto l’album ed in ciascuna canzone.
Mentre sto scrivendo, sono io per prima sorpresa da ciò che descrivo perché, l’album ha il più bell’equilibrio fra orchestrazione, arrangiamento e strumentazione, che non hanno mai avuto prima e non hanno mai più avuto.
Tuttavia, se la metafora dell’incontro di pugilato è richiamata in “Slow Show”, è in “Fake Empire” che c’è un più marcato sguardo duale sul nostro tempo, diviso fra il tormento. Questo brano è divenuto il simbolo di questo album per i significati e per lo sguardo che è capace di dare al tempo che si viveva, (anche se è chiaro che ogni canzone è un elemento della sua narrazione complessiva), ancor prima di essere utilizzata da Barack Obama per la sua campagna nel 2008.
“Fake Empire” narra di come le speranze che hanno accompagnato l’inizio del nuovo millennio, prima dello shock dell’11 settembre, sono state accuratamente ricostruite in una solidità illusoria, speranze ipotecate e sfruttate centinaia di volte, e poi inserite in un paesaggio artificiale, una sorta di falsa costruzione di una narrazione distorta di benessere, una narrazione in cui invece il senso di disorientamento, era il sentimento più comune. Le persone, noi stessi,siamo chiamati a leggere ogni giorno il racconto di un mondo in cammino verso il benessere, ma allo stesso tempo, siamo afflitti dall’incertezza sulla certezza o meno di ciò che è stato raggiunto, di quali degli obiettivi personali possano essere sufficienti ad uno standard in cui tutti sono spinti a produrre sempre di più, sempre di più… mentre allo stesso tempo le disuguaglianze economiche e sociali continuano a crescere.
Quindi, non molto tempo dopo, quello che per The National era un racconto, divenne realtà, forse era un presentimento disincantato pervaso da un malinconico romanticismo, un romanticismo della disillusione, o forse era proprio un resoconto del malessere del tempo. Così come la certezza di ciò che sarebbe seguito all’invasione dell’Iraq non ha potuto impedire che tutto accadesse, il senso di una finta ricchezza comune, di disagio e di caos imminente, non ha potuto fermare il crollo finanziario del 2008 negli Stati Uniti, o fermare il suo effetto sul mondo intero.
E queste cose avrebbero dovuto essere un avvertimento per il nostro presente.

Questo mondo privato, dell’intimità, che ha come presupposto il fatto che la sfera pubblica sia porosa, è per me fonte di ispirazione per la condizione che stiamo vivendo in questo momento. Crea non solo una colonna sonora delle nostre giornate ma, un campo in cui impostare il nostro sguardo sui sentimenti, le speranze e il modo in cui viviamo il presente.
Infatti, tornando a questo album, dopo molto tempo che non lo ascoltavo, mi sono ritornate in mente le ragioni per cui queste canzoni mi hanno lasciato un segno: sono il racconto di come piccoli momenti semplici o drammatici della vita quotidiana siano da cornice per vedere da vicino la lotta contemporanea tra la vita interiore e le strutture sociali di massa.
Le loro descrizioni di piccoli episodi e azioni quotidiane sono in grado di rappresentare le urgenze ed i bisogni, che fanno parte del vivere quotidiano comune a tutti. Ciò che mi colpisce è che, questa sensibilità trova ancora in me una risonanza che non deriva da una mia percezione romantica (non sono una donna romantica), ma si esprime attraverso la forza delle azioni e delle mancanze, di ciò che manca a ciascuno e nella società.. traccia il segno nei sentimenti che mi stanno a cuore nella vita, come l’empatia e la condivisione….e lasciano il segno sul singolo piccolo passo che sono certa, ciascuno di noi può fare ogni giorno.



